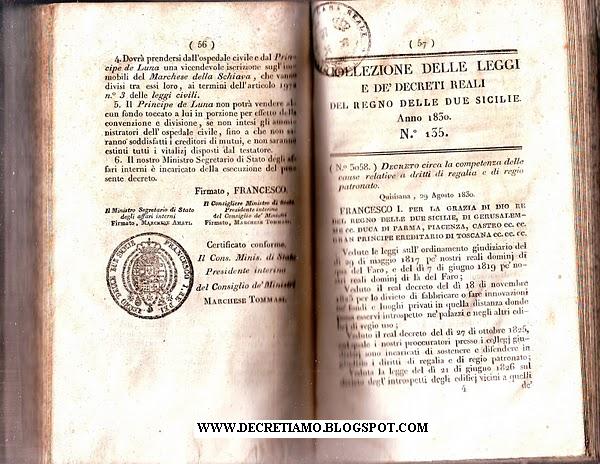Sapevi che Ferdinando I, facendo seguito ad una serie di provvedimenti del 1816, volti ad educare alla scenografia e a sottolineare l'importanza del ballo, volle adottare insegnamenti analoghi anche in altre città. Così decise, in effetti, con un decreto del 1818. Sulla richiesta dell'Intendente (il prefetto di allora) della provincia di Calabria citeriore, in quell'anno il primo sovrano duosiciliano diede il via all'istituzione di un'accademia di musica e ballo a Cosenza, approvandone contestualmente il relativo regolamento.
ARGOMENTI CORRELATI
- Educare alla scenografia (1816);
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
Visualizzazione post con etichetta decreto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta decreto. Mostra tutti i post
domenica 15 marzo 2015
giovedì 11 marzo 2010
Elezioni, decreto salva liste (1848)
Sapevi che nel 1848, dopo la promulgazione della Legge elettorale provvisoria del Regno delle Due Sicilie (1 marzo), seguìta all'adozione della Costituzione, Ferdinando II emanò un decreto che prescriveva la procedura ne' ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali. L'esigenza di un siffatto provvedimento era legato, in particolare, alle modalità e ai termini di presentazione dei reclami per l'esclusione di nominativi dalle liste di eleggibili. Detta esclusione, in base alla citata Legge elettorale, doveva essere dichiarata dalla Giunta elettorale costituita in ogni comune (art. 1), la stessa che era deputata, al tempo stesso, alla compilazione delle liste e a decidere sui reclami. Avverso il rigetto era possibile ricorrere, a norma dell'art. 17 della richiamata legge, proponendo appello alla giunta elettorale del capoluogo del distretto. L'eventuale rigetto anche da parte di questa poteva essere impugnato, in ultima istanza, innanzi al tribunale civile, la cui decisione sarebbe stata inappellabile. In questo quadro normativo s'innestava il successivo decreto, firmato dal terzo sovrano duosiciliano il 22 marzo e pubblicato il 29 marzo 1848. Fondato, come recita la premessa, sull'indispensabile definizione del termine utile per lo sperimento del ricorso innanzi a' tribunali civili, nonché sullo stabilimento di un metodo eccezionale abbreviato per la discussione di questioni essenzialmente di pubblico interesse ed urgenti. Sicché il decreto precisava, in sintesi, che il termine per ricorrere alla Giunte elettorali distrettuali dovesse essere di 3 giorni (art. 1); che nel ricorso, da indirizzarsi al presidente e ai giudici del tribunale civile territorialmente competente e da notificarsi, ove presenti, ai controinteressati, occorreva fornire le motivazioni (art. 2); che il reclamante doveva depositare, nella cancelleria del tribunale, la copia della deliberazione della Giunta impugnata ed eventuali documenti a sostegno nei 4 giorni successivi alla notifica e comunicazione del ricorso, termine disatteso il quale lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile e la decisione della Giunta irrevocabile (art. 3). Il ricorso, presentato nei termini sopra stabiliti, doveva essere discusso, in via sommaria, nella prima udienza del tribunale successiva al deposito (art. 6).
ARGOMENTI CORRELATI
- Il Governo dei Saggi (1821);
- Il presidente del consiglio che (non) manca;
- Ridare vigore alla costituzione del '48 (1860)
ARGOMENTI CORRELATI
- Il Governo dei Saggi (1821);
- Il presidente del consiglio che (non) manca;
- Ridare vigore alla costituzione del '48 (1860)
Etichette:
1848,
appello,
decretiamo,
decreto,
elezioni,
esclusione,
Ferdinando II di Borbone,
interesse pubblico,
legge elettorale,
liste,
procedure,
Regno delle Due Sicilie,
ricorsi,
salva liste,
termini
domenica 7 marzo 2010
Arte dell'interpretazione autentica (1851)
Sapevi che per risolvere conflitti di competenza e possibili ambiguità circa la conservazione dei monumenti Ferdinando II firmò, nel maggio 1851, un apposito decreto. Con il quale, prendendo spunto dal caso del restauro dell'Arco Felice sulla strada da Caserta a Capua e a chi spettassero le relative spese, materia peraltro già rimessa al Consiglio di Stato, il terzo sovrano del Regno delle Due Sicilie intese risolvere la questione con un'interpretazione autentica. Stabilendo in punto di massima che tutte le spese necessarie per la conservazione e restauro dei monumenti antichi o di arte che si trovassero sulle strade fossero poste a carico della Tesoreria generale, delle province, dei comuni e dei privati, a seconda che le strade fossero regie, provinciali, comunali o vicinali. Senza che ciò inficiasse le competenze, già stabilite con decreto del 1839, della reale Accademia di belle arti, in relazione al preventivo parere e connesse prescrizione che questa doveva fornire per i restauri.
ARGOMENTI CORRELATI
- I monumenti non si toccano (1822-1839)
ARGOMENTI CORRELATI
- I monumenti non si toccano (1822-1839)
domenica 28 febbraio 2010
L'Aquila, risparmio senza speculatori (1859)
Sapevi che l'istituzione della prima Cassa di Risparmio del Regno delle Due Sicilie, prevista all'Aquila (e ivi realizzata nel 1862), fu regolamentata il 28 settembre 1859. A quella data rimontava, in effetti, un apposito decreto firmato a Portici da Francesco II. Con il quale si approvava il Regolamento per la Cassa di risparmio in Aquila, formato di 70 articoli. Esso prevedeva che si sarebbe dovuta formare una società anonima composta di privati, che avrebbero apportato i capitali necessari (mille ducati divisi in 50 azioni da venti ducati ciascuna) e prestato gratuitamente la propria opera, esclusa qualunque mira di speculazione commerciale, al fine di fondare il predetto istituto, appunto, nel capoluogo del secondo Abruzzo ulteriore. I portatori delle 50 azioni sarebbero stati considerati socii fondatori e chi fra questi avesse lasciato le azioni a fondo perduto a beneficio dell'istituto socio pio fondatore, mentre sarebbero stati soci ordinari coloro che avessero acquistato almeno un'azione. La Cassa di risparmio, che doveva avere la sede nella casa municipale, sarebbe stata aperta al pubblico la domenica per i depositi e il mercoledì per i prelievi, dalle 9 alle 13. Il ricavato dalla sottoscrizione delle azioni (che avrebbero reso un interesse annuo del 4%) doveva essere sia versato al Monte dei pegni, per concessioni di mutui, sia utilizzato per sconto su titoli di credito esigibili ad un massimo di sei mesi verso comuni e stabilimenti pubblici, sia per anticipo di denaro ai piccoli coltivatori aquilani per le colture dei campi. Il consiglio di amministrazione poteva proporre altri metodi d'investimento, purché fossero sicuri e garantissero facilità e prontezza nelle restituzioni. I depositi delle somme, fino ad un massimo di duecento ducati per "correntista", con un interesse del 4% annuo con almeno due carlini e mezzo, si sarebbero ricevuti volta per volta se non inferiori a grana 5 né maggiori a ducati 20. Chi avesse posseduto sotto altro nome più libretti, il cui valore assommato superasse i 200 ducati, perdeva tutto l'eccedente. Di cui avrebbe beneficiato la Cassa. In base all'art. 49 del Regolamento, ove fossero insorte questioni tra il possessore del libretto e l'amministrazione dell'istituto di risparmio si sarebbe sperimentata la conciliazione innanzi al giudice conciliatore del comune. L'esito negativo della conciliazione non impediva il ricorso al giudice ordinario.
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- In punta di spille (1827);
- Crisi: tasse sul reddito e tagli alle spese (1831)
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- In punta di spille (1827);
- Crisi: tasse sul reddito e tagli alle spese (1831)
mercoledì 10 febbraio 2010
Stampa e privacy (1849)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie ai giornali e ai periodici in genere non era permesso pubblicare né notizie relative ad atti istruttori, a processi e procedimenti in corso, né i commenti dei giudici su qualsiasi materia. Così stabilì, in effetti, un corposo decreto firmato nel marzo 1849 da Ferdinando II. In sostanza il terzo sovrano duosiciliano stabilì, in assenza e nell'attesa di una legge sul diritto di stampa, disposizioni che - da una parte - ne garantissero l'esercizio, disciplinando però - dall'altra parte - il disordine e la licenza de' periodici e delle scritture volanti stampate nel Regno, o provenienti dall'estero. In primo luogo, il citato decreto sanciva che ogni cittadino maggiorenne del Regno, nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non imputato di reati, potesse, al pari di enti morali e società commerciali regolarmente riconosciuti, compilare e stampare giornali, effemeridi, fogli sia volanti sia a fascicoli. Previo rilascio di una dichiarazione all'Intendente e al procuratore generale presso la Gran Corte criminale. E previo versamento, nel caso di pubblicazioni riguardanti materie politiche ed economiche, di una cauzione. Gli stranieri potevano partecipare alla redazione di una pubblicazione, ma non assumerne la proprietà, l'edizione e la responsabilità. In secondo luogo, la pubblicazione doveva avere un direttore o un gerente responsabile, carica che poteva assumere anche il proprietario, figure comunque rigorosamente regnicole e in possesso di tutti i requisiti sopra ricordati. In caso di richieste dell'Autorità, circa l'autore di un articolo non firmato o firmato con pseudonimo o siglato, essi non potevano invocare il segreto professionale, ma dovevano dichiararne il nome, potendo incorrere in caso contrario nel reato di falsa testimonianza. Gli stessi erano obbligati, prima della distribuzione, a cifrare ogni singolo foglio di un solo esemplare, che doveva restare dal tipografo o stampatore, il quale, in assenza di tale adempimento, non era autorizzato a rilasciare le copie. In terzo luogo, i chiamati in causa da articoli potevano esercitare il diritto di replica, con una risposta o una dichiarazione alle quali, indipendentemente dalla lunghezza, non potevano essere aggiunti commenti o note editoriali. Infine, non era possibile pubblicare: le discussioni delle commissioni parlamentari; i dibattimenti dei giudizi penali e, se chiusi al pubblico, di quelli civili; gli atti istruttori delle cause penali in pendenza del giudizio; i voti di ciascun giudice su questioni di fatto e di diritto. La trasgressione comportava la reclusione, oltre ad un'ammenda.
ARGOMENTI CORRELATI
- Tutelare il diritto d'autore (1828)
ARGOMENTI CORRELATI
- Tutelare il diritto d'autore (1828)
Etichette:
brogliacci,
decretiamo,
decreto,
diritto di cronaca,
Ferdinando II di Borbone,
giornali,
intercettazioni,
magistratura,
periodici,
privacy,
processi,
Regno delle Due Sicilie,
riservatezza,
stampa
martedì 9 febbraio 2010
Non bestemmiare in luogo pubblico (1827)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la bestemmia era punita, a seconda del posto in cui era profferita, con la reclusione o con la relegazione. In effetti tale reato, già previsto sotto Ferdinando I nel 1821, fu precisato e inasprito con un decreto firmato da Francesco I nel maggio 1827. In particolare, il secondo sovrano duosiciliano provvide a far sì che se la bestemmia, vale a dire l'empia esecrazione del nome di Dio, o de' Santi, fosse stata pronunciata all'interno di chiese aperte al pubblico o in luoghi in cui si stessero pubblicamente celebrando funzioni sacre, allora il trasgressore sarebbe stato punito con la reclusione; altrimenti, sarebbe incorso nella relegazione. Venne specificato che per luogo pubblico si dovessero intendere le strade e le piazze, i caffè e i bigliardi, le osterie e le cantine, le bettole e le spezierie, oltre a quei luoghi aperti su strade e piazze pubbliche in cui si svolgevano abitualmente delle riunioni.
Etichette:
bestemmia,
Chiesa cattolica,
decretiamo,
decreto,
Dio,
Francesco I,
luogo pubblico,
pena,
reato,
Regno delle Due Sicilie
Distillare la birra con "Archimede" (1833)
Sapevi che il "condensatore Archimede", un macchinario per distillare la birra, venne distribuito, in esclusiva, nel domini di qua del faro del Regno delle Due Sicilie. La relativa privativa, in effetti, fu concessa per cinque anni a Giacomo Power, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto nel febbraio 1833. Con il quale Ferdinando II intese anche dare in esclusiva allo stesso concessionario la distribuzione del collegato raffreddatore tortuoso. Facendo salva, tuttavia, la possibilità per i fabbricanti di birra e per i distillatori di spirito di continuare ad utilizzare i metodi tradizionali o quelli che si sarebbero potuti inventare in futuro.
ARGOMENTI CORRELATI
- L'alcool senza cereali (1859).
ARGOMENTI CORRELATI
- L'alcool senza cereali (1859).
Etichette:
alcool,
Archimede,
birra,
decretiamo,
decreto,
distillazione,
Ferdinando II,
Regno delle Due Sicilie,
spirito
lunedì 8 febbraio 2010
Tutelare il diritto d'autore (1828)
Sapevi che Francesco I promulgò un decreto per assicurare il "copyright" delle opere dell'ingegno ai legittimi proprietari. Così fece, in effetti, nel febbraio del 1828. Con il decreto in questione, composto di sei articoli, fu prescritto che gli scrittori, i compositori, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori potessero godere, vita natural durante, del diritto esclusivo di pubblicare e diffondere (spacciare) le loro opere in tutto il Regno delle Due Sicilie. Il secondo sovrano duosiciliano estese tale diritto all'intera durata in vita delle vedove e agli eredi fino a 30 anni dalla morte dell'autore. Era anche concessa la facoltà di poter vendere ad altri la proprietà intellettuale e il corrispondente diritto di esercizio o sfruttamento.
ARGOMENTI CORRELATI
- Stampa e privacy (1849)
ARGOMENTI CORRELATI
- Stampa e privacy (1849)
Etichette:
assicurazione,
copyright,
decretiamo,
decreto,
diritto d'autore,
Francesco I,
ingegno,
intelletto,
opera,
originale,
proprietà intellettuale,
Regno delle Due Sicilie,
tutela
domenica 7 febbraio 2010
Illuminare le coste (1859)
Sapevi che Ferdinando II volle mettere in sicurezza la navigazione delle coste della parte continentale del Regno delle Due Sicilie, adottando un sistema di illuminazione notturna del litorale e delle spiagge. Così fece, in effetti, approvando nel marzo del 1859 un decreto che prevedeva la realizzazione di una serie di fuochi, ossia di fari. Questi si dividevano in tre categorie: 1. Fari di scoverta; 2. Fari di riconoscenza; 3. Fari di richiamo. I primi dovevano consentire di far luce ai punti più sporgenti del litorale, coprendo anche grosse distanze, in modo da consentire alle imbarcazioni di determinare la propria posizione geografica sul mare. Ed erano previsti a Ponza, Miseno, Capri, Palinuro, Capo Vaticano, Punta del Pizzo, Capo Spartivento, Capo Colonne, Torre S. Vito, S. Paolo in Taranto, Gallipoli, Capo S. Maria, Otranto, Petagna, Forte a Mare, Torre Penne, Bari, Matinata, Vieste e Tremiti. I secondi, quelli di riconoscenza, dovevano indicare la rotta più sicura per entrare nel porto. E dovevano essere ubicati a Infreschi, Paola, Pizzo, Capo dell'Armi, Barletta e Manfredonia. I terzi, infine, servivano per segnalare i contorni delle coste circostanti le rade o l'entrata del porto, in particolare nelle seguenti località: Ventotene, Ischia, Salerno, Orecchie di porco, Sapri, Tropea, Scilla, Crotone, Capo Alice, Monopoli, Termoli, Punta di Penne, Ortona, Pescara, Giulianova e ancora a Gallipoli e Bari. Il decreto imponeva la più rapida realizzazione degli stessi, secondo l'ordine d'importanza della categoria, e fissava l'introduzione di un successivo diritto di lanternaggio, i cui utili sarebbero occorsi per la manutenzione dei fari e dei servizi collegati.
ARGOMENTI CORRELATI
- A vele spiegate (1831-1859);
- Tutti gli uomini del "Francesco I" (1829);
- Le navi, gli scogli e la solidarietà (1825).
ARGOMENTI CORRELATI
- A vele spiegate (1831-1859);
- Tutti gli uomini del "Francesco I" (1829);
- Le navi, gli scogli e la solidarietà (1825).
Etichette:
coste,
decretiamo,
decreto,
fari,
Francesco II,
geografia,
illuminazione,
lanterna,
litorali,
luce,
mare,
navigazione,
notte,
porto,
Regno delle Due Sicilie,
spiagge
giovedì 4 febbraio 2010
Sterminare i briganti (1816)
Sapevi che, dopo la restaurazione, Ferdinando I attuò una dura campagna di repressione contro il brigantaggio. In effetti il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie s'interessò della materia con quattro distinti decreti, promulgati tra il giugno 1815 e il maggio 1816. Con i primi due, siglati a Portici il 14 giugno 1815, intese abolire le liste dei pregiudicati e condonare le pene comminate per i fatti diretti contro il cessato governo, fissando tuttavia un termine di presentazione alle autorità preposte degli individui caratterizzati come briganti, termine scaduto il quale coloro che non fossero rientrati nell'ordine sarebbero stati perseguitati e giudicati con rigore da Corti speciali. Con il terzo decreto, dato a Napoli il 22 aprile 1816, il sovrano borbonico fissò energiche disposizioni per la destruzione e sterminio di alcune bande di briganti, che stavano commettendo ogni specie di misfatto, spargendo da per tutto il terrore e la desolazione, in particolare nelle due Calabrie, in Basilicata, in Molise e in Capitanata. In queste province una speciale commissione doveva formare delle liste di fuorbando, comprendenti gli individui che percorrevano armati la campagna in aperta resistenza della forza pubblica, fra i quali quelli che componevano le bande guidate da' notorj capi Vito Colagiuri, Carlo Cironte, Paolo Negro soprannominato Pecora, Emmanuele Greco ed i fratelli Vardarelli. Per effetto del fuorbando, come recitava l'art. 6 del richiamato decreto, gli iscritti nelle liste erano dichiarati rei di morte, potendo pertanto essere uccisi impunemente da chiunque. Ogni capobanda ucciso conferiva un premio di 400 ducati, mentre se era consegnato vivo alla giustizia si aveva diritto a 600 ducati. I premi erano raddoppiati se l'uccisione o l'arresto fosse eseguito dalla forza pubblica. Mentre la metà del premio spettava nel caso di uccisione o arresto di altri componenti le bande. Era esposto al rigore delle leggi anche chi, scientemente e volontariamente, offriva ai banditi alloggio, aiuti, viveri, armi, munizioni e notizie dei movimenti della forza pubblica. Gli stessi provvedimenti furono estesi, con decreto del 29 maggio 1816, a tutte le province in cui esistevano bande armate di malfattori. Ulteriori prescrizioni al riguardo si ebbero, nel luglio 1817, con un decreto relativo alla formazione e mantenimento delle liste di fuorbando. Preceduto da un provvedimento (febbraio 1817) di Destinazione di alcuni ufficiali dello stato maggiore dell'esercito, presso le diverse divisioni militari, proprio al fine di arrestare i malviventi. Erano destinati a tale compito i maggiori De Sauget (divisione I), Zeno (div. II), Ruiz (div. III), Vial (div. IV), Rodinò (div. V), Giampaolo (div. VI) e il colonnello in seconda Pegnalver (a Napoli), ai quali fu anche ordinato di fare de' giri per descrivere la topografia delle provincie, specialmente le strade. Con lo stesso provvedimento furono destinati, per la tranquillità generale del Regno, il colonnello Cesare Mari come commissario reale in Capitanata, Basilicata, Molise e ovunque la persecuzione delle principali bande de' fuorusciti esigerà la sua presenza, e il tenente colonnello Francesco del Carretto. Quest'ultimo aveva un compito di coordinamento, per dare unità ed assieme alle azioni militari e, quindi, continuità alle attività rivolte a perseguitare incessantemente le compagnie dei malviventi. Infine analoga azione di repressione si registrò in seguito alla promulgazione di un decreto del marzo 1820, in particolare per le zone di confine con lo Stato Pontificio.
ARGOMENTI CORRELATI
- Banditismo di confine (1820).
ARGOMENTI CORRELATI
- Banditismo di confine (1820).
Etichette:
banditi,
banditismo,
brigantaggio,
briganti,
decretiamo,
decreto,
Ferdinando I,
Regno Due Sicilie
Esportare liberamente pece e resina (1830)
Sapevi che Francesco I, volendo favorire l'industria e il commercio del Regno delle Due Sicilie, liberalizzò l'esportazione della pece e della resina. Così fece, in effetti, con un decreto di due soli articoli promulgato in sua vece dal figlio Ferdinando, quale vicario generale, nel gennaio 1830. In particolare, il primo articolo del decreto prevedeva tanto la libera estraregnazione della pece nera, della pece greca e della resina, quanto l'esenzione dei relativi dazi doganali.
Etichette:
dazio,
decretiamo,
decreto,
dogana,
Francesco I,
liberalizzazione,
pece,
Regno Due Sicilie,
resina
martedì 2 febbraio 2010
Mettere alla gogna (1815)
Sapevi che la gogna era prevista come pena accessoria dal codice penale del Regno di Napoli e che, per questo, poco dopo la restaurazione borbonica, Ferdinando I decise di precisare i casi in cui dovesse essere applicata. Così accadde, in effetti, nel settembre 1815, con la firma a Portici di un apposito decreto. Il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie stabilì che la suddetta pena fosse riservata ai condannati ai lavori forzati, sia a vita che a tempo, per i reati di furto, di falso e di falsa testimonianza. La pena della gogna non era applicabile contro le donne.
ARGOMENTI CORRELATI
- Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838);
- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).
ARGOMENTI CORRELATI
- Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838);
- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).
Etichette:
codice penale,
decretiamo,
decreto,
detenuti,
donna,
Ferdinando I,
gogna,
Legge,
Regno di Napoli,
Regno Due Sicilie
lunedì 1 febbraio 2010
Proteggere gli alberi (1842)
Sapevi che nel 1842 le "piantagioni lungo le strade" furono poste sotto la particolare cura e protezione del Governo. Così precisava, in effetti, il primo articolo di un regolamento approvato nel gennaio di quell'anno con decreto di Ferdinando II. La normativa, che riguardava la piantagione e conservazione degli alberi lungo le strade provinciali e comunali, prevedeva che a concorrere allo scopo fossero chiamati: - gli appaltatori delle piantagioni, i quali potevano anche assumere e armare dei custodi; - le autorità civili, in particolare gli agenti municipali e la gendermeria, che potevano arrestare i rei colti in flagranza; - i proprietari o coloni di fondi limitrofi alle strade oggetto di piantagioni. E vietava nei pressi delle piantagioni di stabilire passaggi di strade e il pascolo del bestiame di qualsiasi tipo. Chi procurava danni agli alberi, direttamente o con vetture o con propri animali, doveva essere punito con tre giorni di reclusione e con un'ammenda pecuniaria.
Etichette:
alberi,
conservazione,
decretiamo,
decreto,
Ferdinando II,
natura,
piantagioni,
protezione,
Regno Due Sicilie
domenica 31 gennaio 2010
Abolizione del divorzio (1815)
Sapevi che tra i primi atti di Ferdinando I vi fu un decreto che, abrogando le disposizioni sui matrimoni contratti in Chiesa del Codice civile introdotte durante il decennio francese, abolì il divorzio. Così sancì, in effetti, nel giugno 1915, vietando ai tribunali di dar corso a istanze di divorzio e al contempo sopprimendo le cause pendenti sullo stesso oggetto. Con lo stesso decreto, il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie vietò i matrimoni tra persone divorziate, finché uno dei due coniugi divorziati fosse ancora in vita, mentre lasciò in vigore le norme civilistiche in tema di separazione.
Etichette:
abolizione,
Chiesa cattolica,
codice civile,
decretiamo,
decreto,
divorzio,
Ferdinando I,
Regno Due Sicilie,
separazione
giovedì 28 gennaio 2010
Liberalizzare la pesca del corallo (1856)
Sapevi che Ferdinando II intese favorire la pesca del corallo in diverse aree del Mediterraneo esercitata dalle imbarcazioni battenti bandiera del Regno delle Due Sicilie. Così, in effetti, stabilì, con un decreto del gennaio 1856, con il quale veniva approvato un regolamento costituito di 28 articoli. In sostanza, esso liberalizzava l'entrata e l'uscita dei pescherecci corallini, qualunque fosse la destinazione. Ogni barca, che non poteva avere più di 14 uomini d'equipaggio, doveva essere ben munita di provviste da bocca (biscotti, paste lavorate, patate, legumi, olio, lardo, segale) e di attrezzi utili (canapa lavorata per reti e funi; remi). Il responsabile dell'imbarcazione, che doveva recare sui documenti la dizione di padrone di pesca di corallo, doveva avere almeno 21 anni e vantare un'esperienza quinquennale nel settore. L'esercizio della pesca era disciplinato per i mari della Corsica, della Sardegna, delle Isole Jonie, delle coste d'Africa, della Romagna, oltre a quelli del Regno duosiciliano. Al fine di evitare tensioni e risse, un'imbarcazione non poteva accostarsi a pescare nello stesso scoglio corallino ove si trovasse un'altra barca o dove questa avesse lasciato il segno di occupazione (detto pedagno), ma doveva tenersi ad una distanza di almeno 100 passi da tutti i lati.
ARGOMENTI CORRELATI
- Pesca all'alalunga (1835-1852).
ARGOMENTI CORRELATI
- Pesca all'alalunga (1835-1852).
Etichette:
corallo,
decretiamo,
decreto,
Ferdinando II,
liberalizzazione,
liberismo,
Mar Mediterraneo,
Regno Due Sicilie
mercoledì 27 gennaio 2010
Indulto ai condannati (1860)
Sapevi che uno degli ultimi atti di Francesco II, prima dell'entrata a Napoli di Garibaldi, fu la promulgazione di un provvedimento d'indulto. L'ultimo sovrano delle Due Sicilie appose il proprio sigillo, in effetti, nel settembre 1860, su un decreto di "clemenza" verso tutti i condannati. In particolare, l'Augusto Genitore (così recita testualmente il decreto) determinò di ridurre la pena sia per gli ergastolani (trasformandola a 20 anni di lavori forzati) sia per i condannati ai lavori forzati, per i reclusi e per i relegati (riducendola di un terzo), nonché di condonare a tutti le pene correzionali e di polizia già stabilite. L'indulto seguiva un'amnistia accordata, per tutti i reati politici fino a quel momento commessi, attraverso la promulgazione dell'Atto sovrano del 25 giugno 1860 che concedeva gli ordini costituzionali e rappresentativi del Regno. La stessa fu ulteriormente sanzionata con il successivo decreto del 30 giugno. Il quale, abolendo l'azione penale per tutti gli imputati di reati politici e per quelli che per lo stesso reato fossero già stati condannati, aveva lo scopo d'impedire l'applicazione di alcuni disposti del codice di procedura penale e, quindi, di conferire la massima estensione possibile al provvedimento.
Etichette:
amnistia,
codice penale,
condanna,
condono,
decretiamo,
decreto,
Francesco II,
indulto,
Napoli,
Regno Due Sicilie
lunedì 25 gennaio 2010
Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842)
Sapevi che Ferdinando II, al fine di precisare le disposizioni per l'esecuzione della pena di morte di un militare resosi colpevole di atti di insubordinazione tali d'aver privato della vita il proprio superiore (e in tal caso definito infame), decise che, ove non si fosse potuto utilizzare il laccio sulla forca, il condannato avrebbe dovuto essere "fucilato alle spalle". Così in effetti stabilì con un decreto del gennaio 1842, che si componeva di 4 articoli. Prevista dal codice penale militare del Regno delle Due Sicilie, la pena doveva essere eseguita, con il laccio alla forca (art. 1) o nell'alternativa segnalata sopra (art. 4), entro 24 ore dalla pronuncia della condanna, termine entro il quale il reo doveva essere condotto sul luogo dell'esecuzione, degradato e consegnato al boia (art. 2).
ARGOMENTI CORRELATI
- Mettere alla gogna (1815);
- Sterminare i briganti (1816);
- Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838).
ARGOMENTI CORRELATI
- Mettere alla gogna (1815);
- Sterminare i briganti (1816);
- Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838).
Etichette:
codice penale,
decretiamo,
decreto,
Ferdinando II,
forca,
fucilazione,
infame,
insubordinazione,
militare,
pena di morte,
Regno Due Sicilie,
spalle
sabato 23 gennaio 2010
Puntare a più ruote del lotto (1816)
Sapevi che Ferdinando I, per assecondare le richieste dei napoletani, volle permettere di ampliare la gamma del lotto, facendo aprire nella capitale del Regno delle Due Sicilie appositi botteghini riservati alle puntate per la ruota di Palermo. In tal senso in effetti decise nel novembre 1816, con un decreto per la cosiddetta Lotteria di Palermo. Al fine di facilitare la giocata, ad ogni numero erano associate le stesse fanciulle (definite, con nobile linguaggio, donzelle) utilizzate per i numeri della ruota di Napoli.
ARGOMENTI CORRELATI
- Cuori e denari bollati di diritto (1826);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824).
ARGOMENTI CORRELATI
- Cuori e denari bollati di diritto (1826);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824).
Etichette:
decretiamo,
decreto,
donna,
donzella,
Ferdinando I,
lotteria,
lotto,
Napoli,
Palermo,
Regno Due Sicilie
domenica 17 gennaio 2010
Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838)
Sapevi che Ferdinando II, repuntando i duelli non solo forieri di ferite, talvolta mortali, ma anche - e soprattutto - del principio della vendetta privata in barba alle leggi e alla pubblica autorità, stabilì di vietarli e di punire severamente i trasgressori. Così, in effetti, decretò nell'estate del 1838, sanzionando in 12 articoli quanto segue in sintesi: 1. è soggetto a prigionia e all'interdizione dai pubblici uffici chiunque abbia sfidato al duello altra persona direttamente o per interposta persona o con qualsiasi altro mezzo; 2. Viene punito con la reclusione, con l'interdizione patrimoniale e con la perdita della pensione chiunque perpetri ingiurie, minacce, percosse, ferite contro chi abbia rifiutato la disfida e, se le ferite procurate a questi porterano entro 40 giorni al decesso, con la pena di morte; 3. Sono parimenti puniti gli autori di una disfida che, benché organizzata, sia stata spontaneamente interrotta; 4. Il duello svolto che non comporti né ferite né omicidi dà luogo comunque alla reclusione di primo grado e alla perdita della pensione; 5. La precedente pena vale anche per il ferito; se le ferite non producono danni permanenti o mutilazioni, l'autore è condannato alla pena di secondo grado e alla perdita della pensione; se le ferite portano alla morte dopo 40 giorni dal fatto, la pena da applicare è di terzo grado; 6. L'uccisione o le ferite che portano alla morte in seguito a duello sono considerati come omicidio premeditato; 7. I morti in seguito al duello sono seppelliti in luogo profano, scelto di volta in volta dagli agenti di pubblica sicurezza, senza pompa funebre né segni di onore. Ciò vale anche per i morti a seguito della condanna per duello. Dello stesso non deve rimanere traccia, così come non deve restare memoria delle persone che vi hanno partecipato; 8. La pena decretata con l'art. 1 vale anche per chi si sia fatto volontoriamente portatore di sfide a parole o con scritti; 9. Sono puniti, con le pene previste dagli artt. 3, 4 e 6, anche i padrini, i secondi e gli assistenti al duello; 10. Il reato al duello posto in essere dai militari dà luogo anche al reato d'insubordinazione; 11. Le condanne, in via definitiva, fanno automaticamente decadere i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di corte, cancellando d'ufficio i relativi ruoli. 12. L'azione penale relativa al duello è esercitata d'ufficio dal pubblico ministero e per il giudizio sono competenti esclusivamente le Gran Corti criminali.
ARGOMENTI CORRELATI
- Mettere alla gogna (1815);
- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).
ARGOMENTI CORRELATI
- Mettere alla gogna (1815);
- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).
Etichette:
1838,
decretiamo,
decreto,
disfida,
duello,
Ferdinando II,
ferita,
Napoli,
omicidio,
Regno Due Sicilie
giovedì 14 gennaio 2010
L'importanza del ballo a Napoli (1816)
Sapevi che Ferdinando I, dopo aver assistito ad un esame di ballo, reputò utili le scuole gratuite esistenti a Napoli per l'addestramento dei giovani all'arte della danza, tanto da decretarne il mantenimento, ponendole sotto l'amministrazione del soprintendente dei teatri. In tal senso, in effetti, decise, firmando un apposito decreto da Caserta il giorno di Natale del 1816 (Decreto portante la conservazione delle scuole da ballo stabilite nella città di Napoli n. 593,5° del 25 dicembre 1816).
ARGOMENTI CORRELATI
- Educare alla scenografia (1816);
- Cosenza ama la musica (1818);
- A scuola di diplomazia (1860).
ARGOMENTI CORRELATI
- Educare alla scenografia (1816);
- Cosenza ama la musica (1818);
- A scuola di diplomazia (1860).
Etichette:
ballo,
danza,
decretiamo,
decreto,
Ferdinando I,
Napoli,
Regno Due Sicilie
Iscriviti a:
Post (Atom)
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com