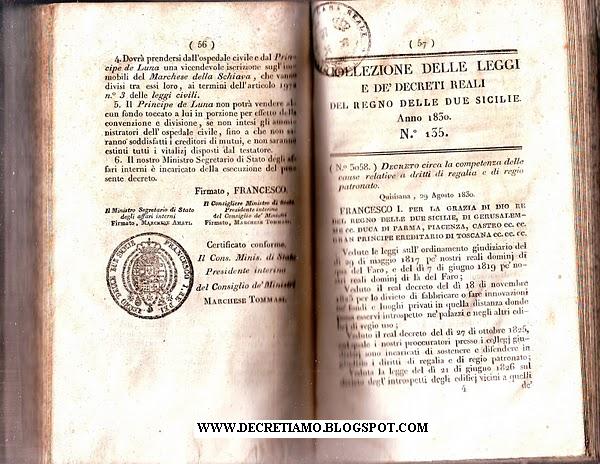Sapevi che Francesco II, mutando opinione sulle concessioni ferroviarie, cui era inizialmente ostile, decise di dare il via alla costruzione di una rete di strade ferrate. Così fece, in effetti, con un decreto dell'agosto 1860, con il quale consegnò l'opera ad un gruppo francese, capeggiato dal finanziere transalpino Gustave Delahante, che aveva fra i propri soci anche i Rothschild. Tale scelta fu caldeggiata all'ultimo sovrano duosiciliano dal suo ministro Giacomo de Martino, da un paio di mesi agli affari esteri, nella convinzione che una concessione al Delahante potesse favorire il sostegno della Francia al Regno delle Due Sicilie. L'autorizzazione alla concessione, data col decreto, prevedeva la costruzione di: una linea dal Tronto a Taranto, che sarebbe passata per Foggia e con delle diramazioni per Otranto, Lecce, Bari, Brindisi, Barletta e Termoli; due passaggi transappennici che permettessero la comunicazione tra la linea precedente e Napoli, attraverso sia le valli del Sele e dell'Ofanto, sia le valli del Volturno, del Calore, del Tamaro e del Biferno. La concessione avrebbe avuto una durata di 99 anni.
ARGOMENTI CORRELATI
- Sudditi al soldo di potenze straniere (1826)
- Illuminare le coste (1859)
QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
Visualizzazione post con etichetta Francesco II di Borbone. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Francesco II di Borbone. Mostra tutti i post
lunedì 30 marzo 2015
Le ferrovie "francesi" di Francesco II (1860)
Etichette:
1860,
Bari,
Brindisi,
decretiamo,
ferrovie,
Francesco II di Borbone,
Francia,
Giacomo de Martino,
Gustave Delahante,
Lecce,
Napoli,
Regno delle Due Sicilie,
Taranto
lunedì 22 marzo 2010
Morti impenitenti (1826)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie era facoltà dei parroci accordare o negare la sepoltura ecclesiastica per i morti suicidati. Tale autorizzazione dipendeva, in particolare, se il suicidio fosse stato volontario, ovvero non tale, in base a quanto già era prescritto dalle norme canoniche. Nell'ottobre 1826 Francesco I stabilì, in effetti, che in caso di negata autorizzazione alla sepoltura, il parroco avrebbe dovuto avvertire le autorità di polizia municipale, per far sì che il cadavere venisse tempestivamente chiuso in un cassa ben condizionata e, senza alcuna pompa funebre, trasportato in un posto adatto per il deposito. I congiunti potevano presentare reclamo al titolare della diocesi. Se fosse stato accolto, il cadavere sarebbe stato seppellito nelle debite forme; altrimenti le autorità avrebbero stabilito un luogo profano per la sepoltura. Tali disposizioni valevano anche per coloro che morivano da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sagramenti.
Etichette:
cadaveri,
decretiamo,
Francesco II di Borbone,
Regno delle Due Sicilie,
sepolture,
suicidi
martedì 16 marzo 2010
Muli fiscali (1859)
Sapevi che negli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie si diffuse la preoccupazione che la diminuzione dei muli potesse creare problemi all'economia e alla sicurezza nazionale, per via dell'utilizzazione che di questi animali si faceva sia nell'agricoltura che nell'esercito. Fu per tale ragione, in effetti, che Francesco II firmò a Portici, nell'ottobre 1859, un apposito decreto. Con il quale stabilì un dazio, pari a 30 ducati, per ogni mulo o mula che fosse oggetto di esportazione.
ARGOMENTI CORRELATI
- Pesca all'alalunga (1835-1852).
ARGOMENTI CORRELATI
- Pesca all'alalunga (1835-1852).
Etichette:
animali,
dazio,
decretiamo,
esportazione,
fisco,
Francesco II di Borbone,
mulo,
Regno delle Due Sicilie
giovedì 4 marzo 2010
A scuola di diplomazia (1860)
Sapevi che Nicolò Luigi Judicone, professore di diritto, fu incaricato di tenere i corsi presso la scuola di diritto internazionale e di storia dei trattati. Che fu istituita, nell'agosto 1860, presso il Ministero degli affari esteri del Regno delle Due Sicilie. Il relativo decreto fu firmato da Francesco II per consentire il metodico ammaestramento alle discipline indispensabili per intraprendere, con successo, la carriera diplomatica. Il corso, come previsto dal regolamento annesso al citato decreto, aveva una durata triennale. Un giorno al mese era dedicato, nell'ambito di una tornata accademica, alla lettura di temi, assegnati a sorte, di diritto internazionale, diritto pubblico marittimo, storia dei trattati, economia politica, politica propriamente detta o scienza delle opportunità, nonché di equilibrio de' poteri in Europa. Gli allievi, che dovevano esercitarsi nello stile di ogni maniera di scrittura diplomatica, alla fine del corso avrebbero dovuto sostenere due esami. L'ammissione al primo era vincolata alla dimostrazione di un diligente impegno nello studio della filosofia, dell'economia politica e delle leggi del regno duosiciliano. Il secondo esame, invece, verteva sul diritto internazionale (comprensivo di quello pubblico marittimo e di quello privato), sulla storia dei trattati dalla pace di Westfalia al trattato di Parigi, sull'economia politica e, in special modo, sulle transazioni economiche con gli altri Stati.
ARGOMENTI CORRELATI
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A vele spiegate (1831-1859).
ARGOMENTI CORRELATI
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A vele spiegate (1831-1859).
domenica 28 febbraio 2010
L'Aquila, risparmio senza speculatori (1859)
Sapevi che l'istituzione della prima Cassa di Risparmio del Regno delle Due Sicilie, prevista all'Aquila (e ivi realizzata nel 1862), fu regolamentata il 28 settembre 1859. A quella data rimontava, in effetti, un apposito decreto firmato a Portici da Francesco II. Con il quale si approvava il Regolamento per la Cassa di risparmio in Aquila, formato di 70 articoli. Esso prevedeva che si sarebbe dovuta formare una società anonima composta di privati, che avrebbero apportato i capitali necessari (mille ducati divisi in 50 azioni da venti ducati ciascuna) e prestato gratuitamente la propria opera, esclusa qualunque mira di speculazione commerciale, al fine di fondare il predetto istituto, appunto, nel capoluogo del secondo Abruzzo ulteriore. I portatori delle 50 azioni sarebbero stati considerati socii fondatori e chi fra questi avesse lasciato le azioni a fondo perduto a beneficio dell'istituto socio pio fondatore, mentre sarebbero stati soci ordinari coloro che avessero acquistato almeno un'azione. La Cassa di risparmio, che doveva avere la sede nella casa municipale, sarebbe stata aperta al pubblico la domenica per i depositi e il mercoledì per i prelievi, dalle 9 alle 13. Il ricavato dalla sottoscrizione delle azioni (che avrebbero reso un interesse annuo del 4%) doveva essere sia versato al Monte dei pegni, per concessioni di mutui, sia utilizzato per sconto su titoli di credito esigibili ad un massimo di sei mesi verso comuni e stabilimenti pubblici, sia per anticipo di denaro ai piccoli coltivatori aquilani per le colture dei campi. Il consiglio di amministrazione poteva proporre altri metodi d'investimento, purché fossero sicuri e garantissero facilità e prontezza nelle restituzioni. I depositi delle somme, fino ad un massimo di duecento ducati per "correntista", con un interesse del 4% annuo con almeno due carlini e mezzo, si sarebbero ricevuti volta per volta se non inferiori a grana 5 né maggiori a ducati 20. Chi avesse posseduto sotto altro nome più libretti, il cui valore assommato superasse i 200 ducati, perdeva tutto l'eccedente. Di cui avrebbe beneficiato la Cassa. In base all'art. 49 del Regolamento, ove fossero insorte questioni tra il possessore del libretto e l'amministrazione dell'istituto di risparmio si sarebbe sperimentata la conciliazione innanzi al giudice conciliatore del comune. L'esito negativo della conciliazione non impediva il ricorso al giudice ordinario.
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- In punta di spille (1827);
- Crisi: tasse sul reddito e tagli alle spese (1831)
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- In punta di spille (1827);
- Crisi: tasse sul reddito e tagli alle spese (1831)
mercoledì 24 febbraio 2010
A vele spiegate (1831-1859)
Sapevi che l'arte della navigazione trovò uno spazio di rilievo nell'ambito dell'istruzione pubblica e privata del Regno delle Due Sicilie, in particolare tra gli anni Trenta e Cinquanta dell'800, anche con l'incremento delle scuole nautiche. Sotto Ferdinando II, in effetti, ne vennero create di nuove e furono adottati numerosi provvedimenti atti a razionalizzare e migliorare quelle di più antica istituzione. Alla nascita delle scuole nautiche di Trapani (decreto del 1831), del Borgo di Gaeta (risoluzioni del 1851 e 1853 e decreto del 1854), di Bari (1856), si accompagnarono significative disposizioni circa quelle di Meta e Carotto, Messina e Reggio Calabria del 1832, di Giarre-Riposto e Siracusa nel 1833, di Castellammare del 1852 e 1853, di Procida del 1855. Infine con Francesco II venne fondata, nel 1859, quella di Torre del Greco. Il controllo di tali scuole dipendeva, a partire dal 1850, dall'Ammiragliato della Marina da guerra. Osservando il decreto istitutivo della scuola nautica di Trapani, si apprende che le materie di insegnamento erano l'aritmetica, la geometria e la trigonometria da studiarsi sui manuali di Vito Caravelli, oltre alle principali nozioni di geografia, e ai trattati sulla sfera e sulla navigazione di Giovanni Fileti. Il lettore ovvero l'insegnante, poi, doveva far conoscere la bussola e illustrare l'uso delle carte piane. Agli alunni che non sapevano leggere erano consigliate le opere di John Locke. Due erano i maestri per le scuole del borgo di Gaeta e di Torre del Greco: uno per le matematiche e la navigazione, l'altro per la lingua italiana e il catechismo. Più articolato il quadro delle discipline da studiare nelle scuole nautiche di Bari e di Procida, cui erano assegnati rispettivamente tre e quattro insegnanti. Le materie, per quella pugliese, erano la scienza del pilotaggio, ossia un corso teorico completo di navigazione per stima e di navigazione astronomica; teoria e pratica di pilotaggio per capitani e piloti di piccolo e grande cabotaggio; le matematiche elementari (geometria, aritmetica, algebra fino alle equazioni di 2°, trigonometria e logaritmi); la geografia; la lingua italiana e la calligrafia. A queste si aggiungevano, nella scuola nautica di Procida, che - secondo gli intenti del terzo sovrano duosiciliano - doveva offire a quella popolazione dedita in massima parte alla navigazione un più largo e compiuto insegnamento, l'aritmetica pratica e il diritto commerciale marittimo, oltre ai rudimenti di scrittura e lettura colle quattro regole di aritmetica per i marinai analfabeti. Insegnamenti simili aveva anche la scuola di Castellammare (di Stabia), dotata di tre maestri, dove in più gli studenti potevano apprendere la lingua francese. Nel relativo regolamento, pubblicato nel marzo 1853, il corso per gli aspiranti piloti d'altura era diviso in tre anni: nel primo si studiava grammatica italiana, calligrafia, geografia, francese, aritmetica pratica e ragionata e geometria piana; il secondo era riservato alla corretta scrittura in italiano e in francese, a stendere una lettera o un rapporto, e a studiare geometria solida, elementi di algebra, dottrina e uso dei logaritmi, canone trigonometrico, trigonometria piana e sferica, nonché l'applicazione pratica alle misure delle figure piane e solide; nel terzo anno, infine, si affrontava la scienza del pilotaggio e si faceva pratica sull'applicazione delle carte idrografiche, come sull'uso degli strumenti astronomici dei marinai. Chi aspirava a diventare capitano o pilota in cabotaggio doveva, inoltre, imparare in un anno la grammatica italiana e l'aritmetica pratica, le principali nozioni della sfera mondana, l'uso delle carte piane e ridotte della bussola e del Locke, il modo di determinare il punto della nave adoperando il quadrante di riduzione e quello di correggerlo mediante la latitudine osservata ottenuta con l'altezza meridiana del sole, ed il come si scovre la variazione della bussola col confronto delle amplitudini del sole utilizzando i logaritmi. Il diritto marittimo si studiava, in tre anni, sulla pubblicazione di Arcangelo Scotto Lachianca.
ARGOMENTI CORRELATI
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A scuola di diplomazia (1860).
ARGOMENTI CORRELATI
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A scuola di diplomazia (1860).
Etichette:
bussola,
discipline,
Ferdinando II di Borbone,
Francesco II di Borbone,
materie,
nautica,
navigazione,
Regno delle Due Sicilie,
scuola nautica,
studio,
vela
venerdì 19 febbraio 2010
Ridare vigore alla Costituzione del '48 (1860)
Sapevi che, in seguito all'Atto sovrano del 25 luglio 1860, l'ultimo sovrano delle Due Sicilie aveva incaricato il Consiglio dei Ministri, formato di 8 persone (Antonio Spinelli, Gregorio Morelli, Augusto la Greca, Giosuè Ritucci, Giacomo de Martino, Niccola Caracciolo, Federico del Re e Francesco Saverio Garofalo), di stendere uno Statuto costituzionale. Il conseguente Rapporto premetteva che le sublimi parole messe per iscritto da Francesco II nel richiamato Atto risuonavano già in tutta Europa, segnando l'inizio di un'era grande e gloriosa. I ministri evidenziavano, però, come uno Statuto costituzionale già potesse rinvenirsi nel diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, in particolare quello che venne largito da Ferdinando II e che, poco dopo la sua concessione, venne sospeso in conseguenza di luttuosi avvenimenti (i noti fatti del Quarantotto). Detta Carta, spiegava il Rapporto, non fu mai abrogata. Per questa ragione i ministri incaricati ritennero semplice e logica la idea che lo Statuto del 1848 fosse richiamato nel suo pieno vigore. Essi chiosavano che, così facendo, il re avrebbe trovato bella e fatta l'opera della quale vuole che questi suoi Stati godano i benefici effetti, concludendo che con un siffatto provvedimento lo straniero avrebbe ammirato la sapienza della Mente Sovrana ed i popoli del Regno, senza dover attendere una nuova stesura, avrebbero già saputo quali fossero i loro diritti e doveri, ricevendo con animo riconoscente il nuovo pegno della volontà del Re per la inaugurazione del regime costituzionale. Fu così che, nella stessa data del Rapporto, cioè il primo di luglio 1860, l'ultimo sovrano delle Due Sicilie richiamò in vigore, con un apposito decreto, la Costituzione ferdinandea.
ARGOMENTI CORRELATI
- Elezioni, decreto salva liste (1848)
ARGOMENTI CORRELATI
- Elezioni, decreto salva liste (1848)
lunedì 15 febbraio 2010
L'alcool senza cereali (1859)
Sapevi che la penuria dei granoni nel Regno delle Due Sicilie dipendeva, principalmente, dalla massiccia utilizzazione che se ne faceva come materia prima nelle industrie di distillazione dell'alcool. Tanto che Francesco II fu costretto a prendere provvedimenti, firmando a Quisisana, nell'estate del 1859, un apposito decreto. Con il quale vietava l'uso del detto cereale nelle distillerie. Considerando peraltro che la povera gente in molte parti dei domini borbonici si nutrisse esclusivamente di quell'articolo. I trasgressori, pertanto, sarebbero stati puniti con la confisca e sottoposti alle pene previste dalle leggi penali.
ARGOMENTI CORRELATI
- Distillare la birra con "Archimede" (1833).
ARGOMENTI CORRELATI
- Distillare la birra con "Archimede" (1833).
Etichette:
alcool,
cereali,
Francesco II di Borbone,
grano,
granone,
Regno delle Due Sicilie
Iscriviti a:
Post (Atom)
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com